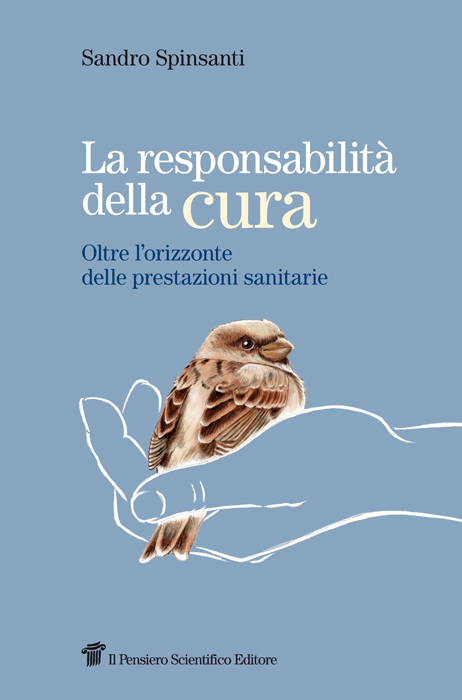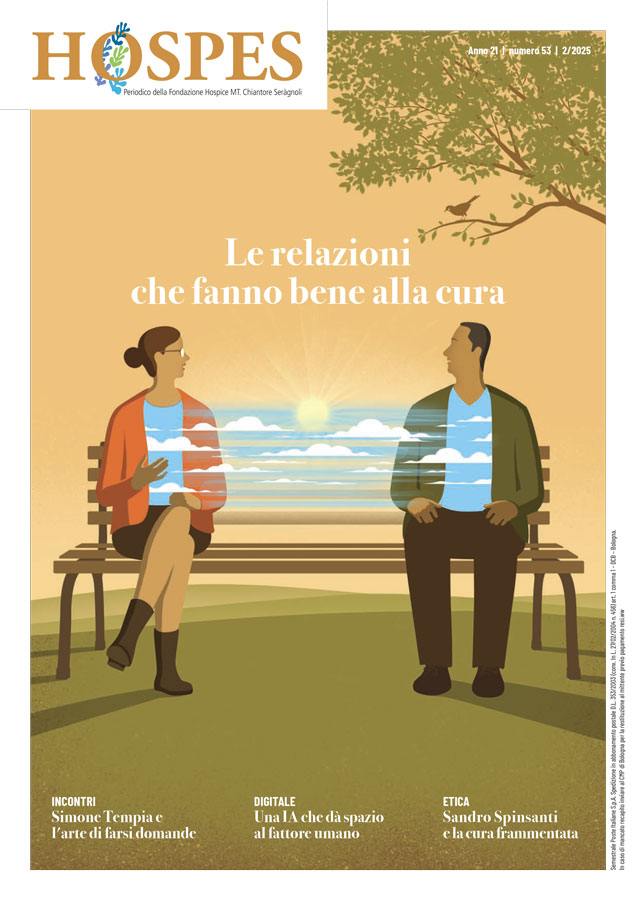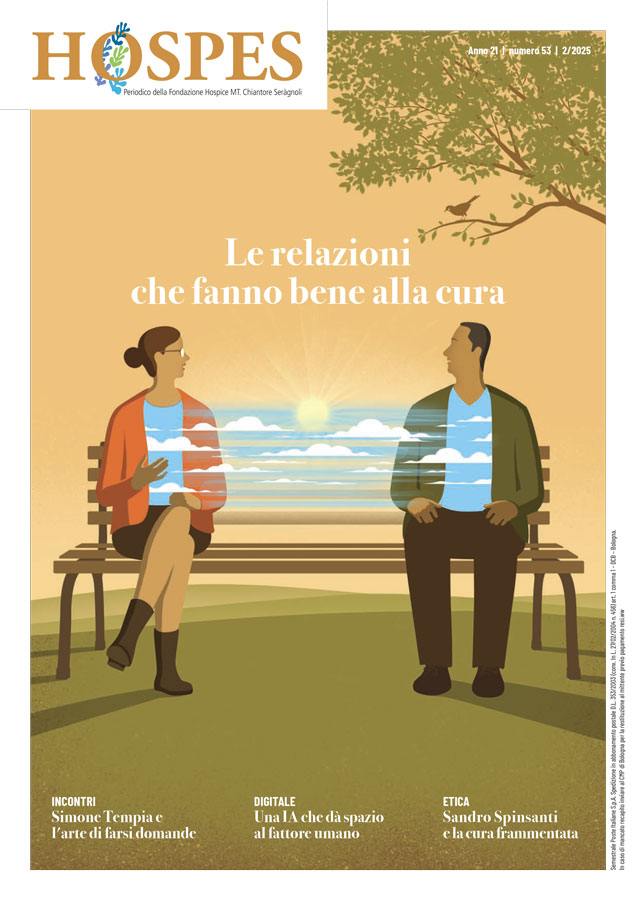
Scarica il numero

Nel suo ultimo saggio, La responsabilità della cura, Sandro Spinsanti – teologo e psicologo, una personalità di riferimento nel campo della riflessione bioetica – si confronta con un concetto di forte impatto, quello della “cura frazionata”. Una definizione che mette in crisi e costringe a ripensare in maniera radicale l’idea del prendersi cura come gesto (e responsabilità) totalizzante, come collante che tiene insieme la vita dell’essere umano dall’inizio alla fine e in tutte le sue espressioni. Un concetto accogliente e umano, che oggi in qualche modo si è spezzato.
Professore, quando e perché la cura è andata in pezzi?
Il sapere medico si caratterizza come una tendenza a sapere sempre più cose su soggetti sempre più piccoli (“to know more and more about less and less”). Da un sapere largo, internistico, si è proceduto verso la specializzazione d’organo. Oggi lo pneumologo ha competenze diverse rispetto al cardiologo e questi dal nefrologo. O addirittura – detto in maniera un po’ caricaturale, ma non siamo lontani dal vero – il cardiologo specialista del ventricolo sinistro ha competenze differenti rispetto al cardiologo specialista del ventricolo destro. Non solo. Se da un lato la scienza medica procede verso l’estrema specializzazione, dall’altro anche la tendenza organizzativa e gestionale della sanità spinge in questa direzione. Siamo passati dall’ospedale che ospitava un paziente per tutto il tempo necessario alle cure (era “hospitale”, appunto), e veniva rimborsato in base ai giorni di degenza, a ospedali parametrati sulle prestazioni erogate. Insidiosamente, dalla cura intesa in senso globale e dai livelli essenziali di assistenza (LEA) siamo passati ai LEP, livelli essenziali di prestazione. Questa duplice spinta, professionale e organizzativa, ha frammentato l’originaria unità del paziente e della cura.
Il “to know more and more about less and less” che lei ha richiamato, però, ha consentito e sta consentendo alla scienza medica di fare passi da gigante. Oggi, da patologie che fino a un decennio fa erano irrimediabili, si guarisce…
Vero, abbiamo una medicina più efficace e questo è estremamente positivo. Ma non è tutto. La focalizzazione sulla patologia, e la tensione estrema al concetto di guarigione, fa perdere di vista la globalità del paziente, mette in secondo piano tutti gli aspetti e i bisogni più ampi che sono sostanziali per chi ha una malattia in quanto – prima di tutto – persona. Il rischio è avere una medicina che finisce per escludere i percorsi di malattia che non hanno e non possono avere una risposta risolutiva dal
punto di vista clinico, che non portano alla “guarigione”, ma che richiedono comunque un accompagnamento. Le cure palliative possono e devono riuscire a ribaltare questa deriva, a reinsegnare a prendersi cura della persona. Curare è accompagnare, non è solo dimettere.
La sfida, per le cure palliative, è proprio affermare questo concetto. Ci stanno riuscendo?
Vorrei poter dire di sì, e spero di dirlo un giorno. Vorrei che quella dei palliativisti fosse intesa – da tutti, a partire dai clinici stessi – come una modalità di cura, e non come una alternativa alla cura. Ancora troppo spesso si sentono specialisti d’organo dire che è “troppo presto” per avviare un percorso di cure palliative “perché il paziente non è ancora terminale”. Io dico che quando si sentono frasi come queste bisogna ribellarsi, perché sono devastanti per chi affronta una malattia e per le persone che ha accanto, ma anche per lo stesso concetto umano di medicina. È la forma più drammatica ed estrema del frazionamento della cura. Bisogna riscrivere un vocabolario della cura, dove certe parole, certe frasi, non devono avere cittadinanza.
Visto che ha citato il vocabolario, apriamolo su un’altra parola che guida le sue riflessioni: “Responsabilità”. Chi può o deve avere la responsabilità di ricomporre questa frammentazione?
Se dovessi scegliere un responsabile per questo grande e importante compito, direi il mondo della formazione. Scuola, università, corsi di specialità… Non ci indigniamo abbastanza per il fatto che tanti clinici, medici e infermieri concludono il proprio percorso formativo senza aver avuto nemmeno un’occasione per confrontarsi con il tema della comunicazione. Forse perché le prestazioni sono esattamente il contrario delle pratiche di cura nelle quali la comunicazione è fondamentale. Saper comunicare con il paziente e con i suoi caregiver non è una competenza che si acquisisce con la buona volontà o con la pratica. Ci vuole formazione. Oggi un clinico che non ha la capacità e la sensibilità per comunicare è un medico a metà. Per essere completo deve essere bravo ad auscultare, ma anche ad ascoltare. A livello legislativo, con la Legge 219 e l’introduzione dei Percorsi Condivisi di Cura, è stato introdotto un principio importantissimo che va proprio in questa direzione. Un Percorso Condiviso di Cura presuppone che ci sia un dialogo tra medico e paziente, che ci sia ascolto, che ci sia la capacità di comprendere anche quel che non viene esplicitamente detto. Non riguarda una prestazione frazionata, ma una visione prospettica e una continuità di relazione.
Sul suo sito c’è un payoff molto interessante, che dice: “La cura: come la sogniamo, come potrebbe essere”. Quanti anni o decenni bisognerà attendere affinché sogno e realtà coincidano?
Ci sono dei piccoli segnali promettenti, ma è necessario una sorta di investimento morale collettivo su questo. Che tutti coloro che fanno formazione siano consapevoli dell’importanza di formare alle medical humanities, all’etica, alla comunicazione. Purtroppo, spesso chi ha a cuore questo approccio si limita a “predicare ai convertiti” e non riusciamo davvero a raggiungere i clinici che più avrebbero bisogno di cambiare prospettiva. Non bisogna desistere, bisogna continuare ad affermare le ragioni della buona cura.
di Monica Beccaro, Responsabile delle attività dell’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa
Mettersi in una postura di ascolto del paziente e della famiglia non è un semplice gesto di cortesia da parte del professionista sanitario, ma è parte imprescindibile del processo di cura. Per molto tempo la capacità di relazionarsi e comunicare è stata relegata a una “attitudine” che il medico poteva avere o non avere, e, in caso non la possedesse, non era considerata una qualità imprescindibile per essere definito un “buon medico”. Non era infatti riconosciuta come una vera e propria competenza che, come tale, potesse essere insegnata e quindi imparata, alla stregua di tutte le competenze clinico-assistenziali che
sono alla base dei percorsi di studio in ambito sanitario. In realtà in Medicina, lo dimostrano studi scientifici e linee guida, la comunicazione efficace, l’ascolto attivo, l’empatia e le capacità relazionali sono strumenti di cura capaci di fare la differenza nella presa in carico dei pazienti che, attraversando l’esperienza di malattia, sono innanzi tutto in una situazione di sofferenza e fragilità non solo fisica, ma anche emotiva ed esistenziale. I dati di uno studio pubblicato nel 2023 sul Journal of Italian Medical Education evidenziano come l’insegnamento delle discipline relative alle Medical Humanities nei 64 Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia italiani sia limitato, disomogeneo e con uno scarso impatto rispetto al totale degli insegnamenti. Per rimanere al passo con una società in continua evoluzione e caratterizzata da differenti approcci culturali ed etici è necessario che i professionisti del futuro continuino ad essere caratterizzati da una formazione scientificamente solida, integrata da strumenti appropriati a riconoscere la centralità e l’unicità dei pazienti, della loro biografia, dei loro bisogni e valori. Sarebbe quindi auspicabile che già a partire dai Corsi di Laurea dei professionisti sanitari fosse dato uno spazio adeguato ad approfondire i processi relazionali e le strategie comunicative che possono contribuire a plasmare Curanti nel senso più esteso del termine. Proprio per questi motivi nei percorsi formativi in Cure Palliative e Cure Palliative Pediatriche promossi dall’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa e dalla Fondazione Hospice, largo spazio è lasciato a questo ambito, attraverso l’utilizzo di una didattica attiva e innovativa che trova negli strumenti dei Laboratori e dei Role Playing una modalità di insegnamento efficace per rafforzare le competenze relazionali e comunicative che spesso non hanno trovato una risposta appropriata nei percorsi di studi ma che sono una risorsa fondamentale per “aver cura” della persona ancor prima che del paziente.